Coronavirus trittico / Coronavirus triptych: recovering ground within and without in Italy.
La zona gialla / Zone Yellow: finding each other one year later, and thirty
Andrea Ballabio
Trent’anni. K ci aveva messo trent’anni a capire che qualcuno gli voleva bene. Non ci aveva semplicemente fatto caso, per una forma di presbiopia mentale che lo portava a considerare solo ciò che era distante nello spazio e nel tempo.
Ma adesso erano lì, in cucina, lui con le gambe allungate sotto il tavolo e lei in piedi di spalle, che armeggiava con la moka. Anche questa era una costante del loro aborto di storia d’amore mai nata, lui entrava – dopo una settimana o dieci anni, senza differenza – e appena svincolatosi dall’abbraccio di saluto diceva: fammi un caffè. Niente forme di cortesia, nessun per favore. Era l’imperativo che si usa con gli intimi, con i familiari, e diceva da solo già tanto.
– Sei sempre uguale, hai pochi capelli grigi – disse la donna mettendo in tavola la tazza di caffè.
– Tu neanche quelli…
– Li tingo, cosa credi? Il tempo passa per tutti.
– Li hai tinti bene, non me n’ero accorto. Poi i dettagli non sono il mio forte, almeno non questi. Trova un posacenere o analogo.
O analogo. E ancora l’imperativo, senza chiedere ovviamente il permesso di fumare. Senza regole, questo era il punto nodale, senza quelle regole che lei non aveva fatto altro che rispettare: studentessa, fidanzata, moglie, madre. Sempre rispettando scrupolosamente le regole del gioco, e senza neanche un’ammonizione, un fischio dell’arbitro, un richiamo verbale. Forse per questo amava l’uomo, che invece fin dall’infanzia non aveva collezionato altro che cartellini colorati, stando alla metafora calcistica.
Bevevano caffè, in silenzio. In fondo non c’era assolutamente niente da dire, avevano una buona parte dei ricordi in comproprietà. Era inutile rivangare.
Tutto d’un tratto la donna decise che mezza vita di cose non dette poteva bastare, non ce ne sarebbe stata un’altra mezza prima del salto nel buio. Parlò:
– Vengo via con te, oggi.
– Non dire cazzate, hai famiglia.
– Sono già grandi, si possono arrangiare senza di me. Già lo fanno, in fondo.
– Dove vado è pericoloso, in due è ancora più difficile passare. È vietato.
– È vietato? Da quando fai attenzione a cosa è o non è vietato? – lo canzono’.
– Questa volta è vietato davvero.
La donna cominciò a piangere, senza singhiozzi, in silenzio. Queste troie ti fottono sempre, pensò K, in un modo o nell’altro. Anche e soprattutto con le lacrime. Si pentì subito della parola troia riferita a lei, rivide loro due bambini, lei che gli gridava di non arrampicarsi così in alto sull’albero. Con quella voce dolce e stridula che non gli era più uscita dalle orecchie.
– Va bene. Ti porto. Prendi solo i documenti e un cambio, non devono pensare che andiamo lontano. Se ci fermano, tu sei mia moglie. Tanto, una più una meno…
La donna lo guardò. K immaginò che stesse unendo le braccia sopra la testa, come prima di tuffarsi. Poi la vide correre in camera a prendere la roba. Senti’ il rumore del tuffo.
L’auto procedeva per strade secondarie, in mezzo ai campi umidi di brina. Verso sud all’incirca. Non parlavano, lei teneva una mano sul cambio, assieme a K. E a lui sembrava che non stessero scappando, ma che andassero a una festa in qualche posto lontano, come facevano da ragazzi. E quasi non gliene fregava più niente che li potessero beccare, avrebbe guidato all’infinito con quella mano leggera sopra la sua.
Dopo una curva in pieno sole, lei chiese:
– Come è la zona gialla?
K non trovò subito le parole. Poi disse:
– È bello… Ci sono tanti bambini per strada, poi quando hai fame puoi andare in un locale, ti siedi e mangi.
– Se è così bello, perché tornavi spesso? Avresti potuto startene sempre lì…
K non riuscì a guardarla negli occhi mentre diceva:
– Ero tornato a prenderti.
Kurtz, Homeland, 25.1.2021, 00:41
Il tempo ritrovato/ Time regained: hearing the alarm to attend to oneself
Rosa Quaranta
Era una domenica del 23 febbraio dell’anno 2020 e da qualche giorno nel lodigiano era scattato l’allarme rosso pandemico. Quel 23 gironzolavo a piedi in una Milano spaventata e quasi deserta fotografando ogni cosa possibile, un’ombra, una foglia, un frammento di natura, uno scorcio di paesaggio urbano, finché la telefonata di un amico mi sorprese sola e indifesa: “che fai in giro? Non senti quello che sta succedendo?” Riattraversai a piedi la città, mi chiusi in casa ben prima del lockdown ufficiale e ne uscii con cautela e prudenza diversi mesi dopo. È trascorso quasi un anno, mancano 8 giorni al suo compimento, ma non ho ancora ufficialmente superato la sindrome della capanna. Lo stato di allarme sanitario generale continua ad offrirmi un’ottima scusa per procrastinare una serie di necessari adempimenti: trovare un lavoro, avere degli impegni sociali e comunitari, e degli appuntamenti mondani. Nessuno di questi compiti è in agenda, non voglio, semplicemente ho bisogno di me stessa, di stare in mia esclusiva compagnia e di godere di tutto questo tempo inaspettatamente ritrovato. Forse è la prima volta che non ho sensi di colpa ad affermare la volontà di non aver voglia di fare o essere una serie di cose che pare siano molto importanti e identitarie per un individuo adulto. Ecco! Posso dire che questa emergenza sanitaria mi ha permesso di assecondare con naturalezza, e senza l’opposizione della coscienza, la mia naturale volontà di non aver voglia. Sono felice di non aver voglia, felice di non incontrare, di non avere l’impegno del mercoledì, del giovedì, la tirannia del weekend, e l’assillo della sveglia dal lunedì al venerdì. La più grande scoperta che ho fatto in questi mesi è che non ho voglia. E se anche vi fosse in me un desiderio vorrei che mi sorprenda a poco a poco, che metta radici con dolcezza e produca germogli con amore, senza fretta, assecondando lealmente il tempo nuovo.
Camminare / Walking: tree-lit routines, physically and mentally, in solitude
Vera Tisot
È passato quasi un anno dall’inizio della pandemia, è domenica, sono le cinque di sera, ed esco per una lunga passeggiata con la mia cagnolina. La strada che percorro nei campi con la mia cagnolina è costellata da quelle piccole sacralità quotidiane, quelle piccole preziose scenette, che sono l’incanto delle nostre insignificanti, microscopiche, a volte ridicole, vite anonime. Per esempio, quando cammino a testa bassa per un lungo tratto e ad un certo punto cerco con lo sguardo la mia cagnolina, proprio in quell’istante, la sua ombra arriva trotterellando al mio fianco, come se avesse sentito la mia domanda: “Dove sei?”, e avesse risposto “Sono qua”. Quando conosco perfettamente il sentiero che sto percorrendo nella campagna e non vedo l’ora di arrivare in quel punto dove, se c’è bel tempo, e sono quasi le cinque di sera, e sta calando il sole, si vedono benissimo le vette delle montagne dietro l’intenso verde degli introversi cipressi e gli occhi allora iniziano a viaggiare leggeri nell’indaco del cielo. Quando una folata di vento fa vibrare le foglie sui rami e in quel fruscìo senti i versi di una poesia di Sbarbaro che fa “Oramai se qualcuno invidio, è l’albero, essere un albero, un comune albero”. Quando ti stacchi da quell’incantesimo con l’albero e ti accorgi che il tuo cane ti sta guardando molto incerto, da un bel po’ di minuti, probabilmente. Quando riesci a fiutare nell’aria l’odore dell’erba e della terra. Quando sei lì che vorresti solo sguazzare nella tua selvatica misantropia e invece arriva il mondo, il mondo delle persone come te, il mondo che si mette su quella stessa strada dove sei te e ti vuole raccontare a tutti i costi del loro esistere, perché ne ha un’innata necessità, un fisiologico bisogno di farti vedere i segni del suo isolamento, del suo sentirsi solo senza nessuno, smarrito, senza più nemmeno sé stesso. Quando proseguo successivamente il mio cammino e capisco che per fortuna sto camminando ancora in compagnia di me stessa, e che forse la vita non mi sta ancora scappando via in modo del tutto inconsapevole. Quando, dunque, avanzo e penso che questo semplice camminare sia un modo per avvicinarmi al senso e all’autenticità della mia minima esistenza, un modo per sentire la voce della mia solitudine, quel luogo di quiete, quell’eremo della mente che mi avvia al pensiero. Quella particolare abilità del nostro sé che sa portarci davanti all’interrogativo: “Cosa vuoi dire? Cosa vogliamo dire? Cosa vogliamo dire per esempio quando pronunciamo la parola amore, la parola vita, morte”. Cosa intendiamo quando parliamo di lutti da elaborare, cosa intendiamo per affetti, per perdita di affetti, per la scomparsa di milioni di affetti. Come li vediamo questi segmenti, questa infinita sequenza di persone disposte orizzontalmente sotto la terra. Che senso diamo alla parola calore, alla parola empatia, alla parola dolore. Cosa significa essere abbandonati, dimenticati. Dimenticati lì sotto la terra. Dimenticati sulla strada, a casa, al lavoro, a scuola, alle frontiere. Cosa vogliamo dire quando diciamo donna? Una donna uccisa per ogni giorno di questa pandemia, una donna licenziata per ogni giorno di questa pandemia. Cosa intendiamo per salute, per solidarietà, per responsabilità. Cosa intendi dire precisamente quando dici assenza della politica, quando dici democrazia, oppure disprezzo per la democrazia. Cosa significa ‘aria di semilibertà’. Cosa significa libertà? Libertà di decidere, libertà di scegliere, libertà di conoscere il più possibile per essere libero di scegliere. Sono domande che vengono a bussare nelle nostre solitudini, se siamo ancora in grado di entrarci dentro. Perché forse ci siamo sentiti inumanamente isolati, senza essere capaci di stare intimamente da soli. E di pensare da soli. Siamo da molto tempo seriamente malati. Quel tipo di malati che se la prendono con lo specchio, se la loro faccia è diventata storta. La solitudine in quegli attimi arriva con il suo mantello blu e il suo profumo di neve fresca e la sentiamo rivolgerci ancora una volta la sua istanza. Cosa intendi pensare? Cosa intendi fare, per pensare con te stesso? Dedicare un pensiero a qualcuno, esaminare, valutare, considerare attentamente, prendere il tempo, concepire un’idea, immaginare, connettersi con il pozzo emotivo della propria lingua, sentire nelle parole che si pronunciano quella vena di profondo sentimento che serve a irrorare le nostre singole biografie. Riuscire a stare nel freddo ad osservare il buio, stringendosi nelle spalle, per poi alzare gli occhi di colpo e vedere la luna. Il mondo intorno a noi che ci dà un colpo, una botta, ma forse anche una carezza.




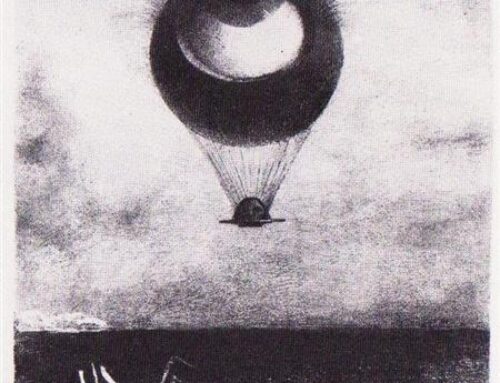

Leave A Comment